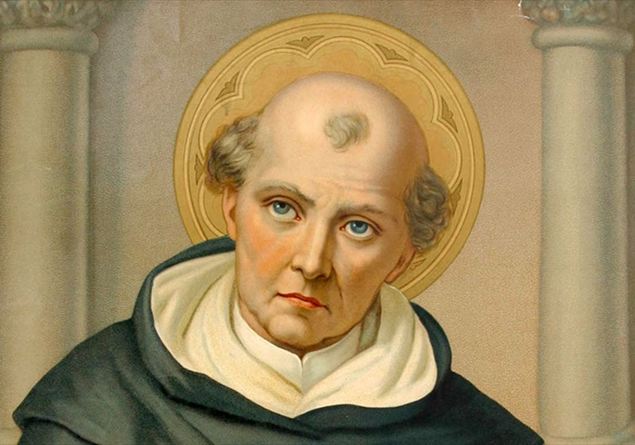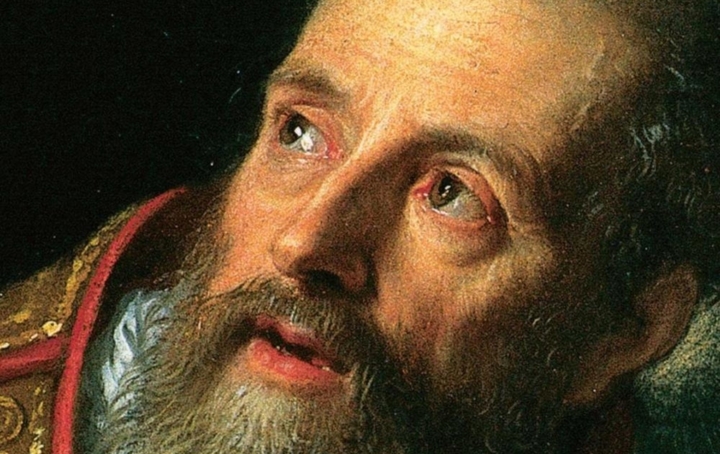Hannah Arendt e Martin Heidegger: l’intenso legame sentimentale tra i più grandi pensatori del ‘900.
Hannah, la riconciliazione è qualcosa che nasconde in sé una ricchezza che noi dobbiamo diffondere fino alla svolta in cui il mondo oltrepassa lo spirito della vendetta. Così scrive Martin Heidegger da Messkirch ad Hannah Arendt, il 6 maggio del 1950. Ci sono voluti oltre vent’anni di silenzio perché il filo spezzato di quell’antico affetto si riannodasse su iniziativa di Hannah stessa. Il carteggio epistolare fra i due amanti, conosciutisi all’università di Marburg nel 1925, quando un trentaseienne professore, sposato e con due figli, restò incantato dall’intelligenza di un’allieva diciannovenne, molto restituisce di quello che fu una relazione nata sul canovaccio di un amore irrealizzabile, tanto distanti apparivano fra loro.
Tuttavia le lettere ci mostrano come sia accaduto per i due amanti d’oltrepassare questo impossibile, vivendosi un affetto diventato storia nella Storia, la cui traccia è riuscita a sopravvivere alla Storia stessa e alle sue colpe.
E forse è proprio questo ad aver salvato un rapporto tra due intelligenze travagliate dal finire nel pattume delle miserie umane e resta intatta per il lettore la sfida di oltrepassare la freddezza del dato di fatto che fa di Heidegger soltanto un filosofo sostenitore del regime nazista e di Hannah Arendt una filosofa ebrea in fuga. Oltre il mero dato, infatti, diventa possibile scoprire che due come loro, dicevamo distanti anni luce da ogni punto di vista, siano riusciti ad accogliersi reciprocamente.
Il carteggio: un viaggio nell’affettività di Hannah Arendt e Martin Heidegger
La prima parte del carteggio, datato 1925/1932, è un viaggio nella sfera dell’affettività di un uomo e una donna che si intreccia inevitabilmente con la speculazione filosofica. Un viaggio nell’intimità con tutte le conseguenze del caso per chi legge e cioè scoprirsi a spiare in punta di piedi, come intrusi non invitati, quella condivisione di pudori che appare così lontano da un tempo che sembra aver dimenticato la bellezza di un amore vissuto come attesa dell’altro.
Quando la bufera sibila intorno alla baita, trascorro una pausa di tranquillità sognando l’immagine di una fanciulla che con l’impermeabile, il cappello calcato fin sopra i grandi occhi quieti, entrò per la prima volta nel mio studio e, timida e riservata, diede una breve risposta a tutte le domande ed è allora che riporto l’immagine agli ultimi giorni del semestre e solo allora capisco che la vita è storia.
Scrive Heidegger alla diciannovenne Hannah il 1 maggio 1925:
Carissima! L’amore sarebbe ancora grande fede, che sorge con esso nell’anima, se non gli rimanesse che questo da tenere in serbo, da aspettare e custodire? Questo aspettare l’amato è la cosa più meravigliosa perché in esso l’amato rappresenta proprio il “presente”. Con questa fede, lascia che io abiti il luogo più intimo e puro della tua anima.
E ancora in una lettera di pochi giorni dopo:
E cosa possiamo fare, se non unicamente aprirci l’un l’altro e lasciar essere ciò che è. (…) Sereni di essere ciò che siamo. E tuttavia ciascuno vorrebbe “dire” all’altro e aprirsi; ma potremmo dire soltanto che il mondo non è più il mio e il tuo ma è diventato il “nostro” e che quanto facciamo e cerchiamo di raggiungere non appartiene a me o a te, ma a noi.
(…)
Ti ringrazio per le tue lettere perché mi hai accolto nel tuo amore mia carissima. Sai che questa è la cosa più difficile che un uomo debba sopportare? Per tutto il resto ci sono vie, aiuti, confini e comprensione soltanto qui tutto significa: essere innamorato= essere sospinto all’esistenza più autentica.
L’intimità secondo Heidegger
Trapela con una spietata chiarezza cosa sia intimità per Heidegger: viversi per ciò che si è, senza quell’ansia di caricare la relazione di aspettative di perfezione che inquinano la promessa di un mutuo donarsi. E’ tutto già perfetto, perché quel noi ha come perimetro e sostanza una sola immagine: quella dell’amata per ciò che già è e non per ciò che ci si aspetta che sia.
Molto spesso in queste lettere Heidegger ripete una frase attribuita a Sant’Agostino: Voglio che tu sia ciò che sei. Non di più, non di meno e una profonda gratitudine le verga: qualcosa di straordinario sta accadendo e cioè la possibilità, che sembra avere del miracoloso, di stare accanto all’amata mentre si dischiude, con le incertezze della giovane età, alla vita.
Non è soltanto un sentimento, è una fede incrollabile che affonda le radici non in un ideale, ma nella solidità di ciò che lei è già e di tutto quello che è la sua storia. Soltanto questa fede, promette Heidegger, resiste alle intemperie del destino, che non mancheranno. Il perché della felicità è, dunque, questo: Che l’amore c’è, che può esserci. Cioè che ha la forza invincibile di un’esperienza, senza limitarsi ad essere mera promessa.
L’amore tra Hannah Arendt e Martin Heidegger e l’incalzare della Storia
Non è facile per Hannah amare il suo professore; avere a che fare con la sua solitudine creatrice, che impone lunghe assenze per dedicarsi anima e corpo alla speculazione. Esperienza grandiosa e infame allo stesso tempo interrompere i rapporti in questi momenti, come lui stesso ammette scusandosi nelle lettere. Ma Hannah Arendt ha la sua vita da vivere e l’incalzare degli eventi, nella Germania nazista, la porterà a prendere commiato dal suo professore, con il quale i rapporti erano rimasti anche dopo il primo matrimonio di lei, fallimentare, con Günther Anders, mentre lui aveva proseguito con la sua vita di marito e padre di due figli.
L’ultima lettera del primo periodo data nell’inverno del 1932/33 quando Hannah chiede ragione delle “dicerie” sull’antisemitismo di Martin:
Le dicerie che ti inquietano sono calunnie, del tutto simili ad altre esperienze che mi sono toccate negli ultimi anni. Che difficilmente io abbia potuto escludere gli ebrei dagli inviti di istituto risulta dalla circostanza che negli ultimi quattro semestri non ho avuto nessun invito in istituto. Che poi io non saluti gli ebrei è una calunnia così maligna che me la ricorderò per il futuro.
Le accuse di antisemitismo ad Heidegger
Ci si immagina tutta l’inquietudine che ha portato la Arendt a chiedere lumi; trapela il sentore di una ferita aperta dal si dice, dal raccogliere voci sparse che stridono con quello che lei sa di Martin. Il carteggio riprende soltanto nel 1950. Hannah ormai vive e lavora in America ed è lei a mettersi in contatto per prima con Heidegger, il quale comincia la lettera che segna la ripresa dei rapporti, con queste parole:
Cara Hannah, sono lieto di avere l’occasione di proseguire adesso, in un periodo più tardo della vita, il nostro iniziale incontro come qualcosa che rimane.” E quello che rimane, scriverà più tardi Hannah in una lettera del 1967, “è dove si può dire: inizio e fine sono sempre ancora la stessa cosa.
Non se lo scriveranno mai esplicitamente cosa è rimasto di quel primo incontro. Sappiamo soltanto, attraverso le considerazioni filosofiche nelle lettere, che non di relazione si è trattato, ma di una vera e propria appartenenza.
Nel silenzio di ciò che non è scritto, azzardiamo che forse la memoria di quell’antico pudore, di quella grazia nell’essersi reciprocamente donati offrendosi l’un l’altro senza riserve, deve aver lasciato traccia come un’impronta pesante scolpita nella roccia degli eventi se è riuscita a resistere a dubbi, parole non dette e macerie di un odio che ha fatto scorrere troppo sangue.
La Hannah Arendt che ricuce i rapporti è una donna radicalmente diversa. Come scrive lei stessa in una lettera, dopo aver incontrato Martin, stavolta con la moglie Elfride, di cui possiamo immaginare e non dobbiamo fare neppure un eccessivo sforzo, perché nelle lettere è accennato il disappunto nel sapere quanto sia stata importante per il suo Martin:
Non mi sono mai sentita una donna tedesca, e ho smesso da molto tempo di sentirmi una donna ebrea. Mi sento quello che sono in realtà, una donna che viene da lontano.
Scriverà Heidegger più in là, quasi sfogandosi:
Per quali inferni deve ancora passare l’uomo, prima di riuscire a capire che non è lui a produrre se stesso?
Sanno entrambi che è lungo ogni sentiero che passa per la prossimità, come scrive il maturo professore in una poesia posta in calce ad una lettera alla Arendt.
E in effetti, si coglie appieno questa difficoltà: farsi vicini, almeno nel loro caso, ha avuto il drammatico significato dell’esperienza di una lunga e dolorosa lontananza. Chiaramente il tenore delle lettere, dal 1950 fino al sopraggiungere della morte della Arendt nel 1975, è diverso, così come sono diversi entrambi.
Adesso sono solo due filosofi di chiara fama e due persone che a fatica si stanno riprendendo dalla Storia a scriversi e nello scambio cordiale di pensieri e incoraggiamento reciproco per il proprio lavoro, sembra sopito quel quieto e profondo amarsi giovanile, pur rimasto custodito in qualche anfratto della memoria. Nonostante le parole scritte, il non detto è il protagonista assoluto di questa relazione nella maturità e per certi versi non sembra assurdo ritenere che lo sia stato anche nel primo periodo. Il non detto è il linguaggio del pudore (e della poesia, scrive Hannah Arendt in una lettera del 1967 a Martin, riprendendo Klopstock).
Cosa succeda dentro questo silenzio simbolico, regno assoluto dell’inesprimibile dove la parola debole e parziale non è ammessa a cittadinanza e il rischio di non riconoscersi resta alto, è difficile, appunto, dirlo.
*Nel 1924, in una giornata d’autunno, la giovane studentessa Hannah e il professor Heidegger si conoscono a Marburg. Hannah ha 19 anni. Martin 35, una moglie e due figli.